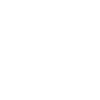Eremo di San Giorgio
Ultimo aggiornamento: 3 maggio 2023, 12:25

Vi si giunge da Conche o da Caino passando per la valletta della Madonna delle Fontane.
Da principio fu probabilmente una piccola cappella di origine benedettina.
Passò poi agli Umiliati come S.Emiliano di Sarezzo. Le sue origini si stimano antichissime, forse risalenti al secolo XIII.
La chiesetta ha un'abside concava; un'arcata la divide dall'atrio abbastanza ampio.
Sulla destra sta addossato il romitorio: un ambiente con focolare e forno e due ambienti sovrapposti con a lato il pozzo e una tettoia. Recentemente sottoposta ad opere di restauro presenta affreschi riguardanti tra l'altro "L'annunciazione", i "Simboli degli Evangelisti", una "Madonna col bambino e San Rocco" e un "Gruppo di Santi" tra i quali il titolare.
"San Zorzi della Corna, l'eremitorio fuori della Terra in cima al monte detto Corna non è officiato ma vi habita del continuo l'eremita giovane che veste di beretino e vive di elemosine".
Con queste parole, nel 1609, Giovanni da Lezze nel suo "Catastico Bresciano" descrivendo il territorio di Caino accennava alla chiesetta di San Giorgio.
L'antico eremitaggio era allora già da secoli tenacemente abbarbicato all'isolato spuntone roccioso che sovrasta la valle a 1125 metri d'altezza.
Le sue origini, non note con certezza, vengono fatte risalire ai primi decenni del XIII secolo o addirittura alla fine del secolo precedente. Certo è che nel corso del 1200 rappresentava già un importante e noto punto di riferimento religioso per le popolazioni circonvicine se il 21 maggio 1291, da Orvieto, papa Nicolò IV annunciava la concessione di un'indulgenza di un anno e quaranta giorni per i pellegrini che vi si recavano nella festa di San Giorgio e negli otto giorni seguenti.
Secondo Mons. Fappani, fu originariamente una "grangia", cioè un rifugio per una piccola comunità benedettina (forse dedita alla pastorizia) collegata in qualche modo con gli Umiliati che erano in Conche e più tardi con le Domenicane di S. Caterina che agli Umiliati si sostituirono nel piccolo convento presso la chiesa eretta da San Costanzo.
I fondatori vollero il piccolo complesso dedicato al grande martire orientale il cui culto si diffuse largamente in occidente durante il dominio longobardo: S. Giorgio. Venerato dapprima come santo guerriero protettore di castelli, rocche, borghi e paesi, ma anche protettore dei campi e dei contadini e poi, in seguito alle prime crociate, come difensore della fede, S. Giorgio doveva rappresentare il protettore ideale per una piccola comunità religiosa, isolata, dedita alla preghiera e al lavoro, esposta ai pericoli di un'epoca che vide lo scatenatsi di sanguinose lotte feudali e il serpeggiare di tante devastanti eresie.
La chiesa, ampliata e ristruttura dalle Domenicane di S. Caterina, venne decorata con un ciclo di affreschi di grande bellezza eseguiti nel 1512, l'anno del sacco di Brescia da parte delle truppe francesi di Gastone de Foix.
Gli affreschi, oggi purtroppo gravemente deteriorati, rappresentano secondo una disposizione classica Dio Creatore (in alto), il Cristo Redentore (al centro), l'Annunciazione e gli Evangelisti (ai lati) e numerosi santi e martiri (in basso) nonchè la croce di S. Bernardino e il suo monogramma.
All'esterno di questo ciclo su una parete laterale fu eseguito, probabilmente da mano diversa, un affresco di S. Giorgio, affresco che nei decenni successivi non fu ritenuto adatto a rappresentare adeguatamente il titolare del sacro luogo.
Ecco allora, a cavallo tra '500 e '600, i Cainesi commissionare una pala degna di questo nome: quella pala oggi esposta nella parrocchiale.
Gli esperti la attribuiscono a Grazio Cossali (Orzinuovi, 1563 - Brescia, 1629) che operò nel bresciano, milanese, cremonese, nell'alessandrino e in Lomellina nel periodo 1580-1626 riscuotendo vasta ammirazione per la perizia tecnica, l'uso di colori caldi e forti, la straordinaria capacità di trasporre molto rapidamente ampie scene d'ispirazione controriformistica su grandi tele.
Anche in questa circostanza i nostri antenati agirono con lo stile che sempre li contraddistinse: non lesinando i mezzi si rivolsero ad uno dei migliori artisti locali del tempo. In effetti stupisce come un piccolo paese tra i monti, con scarsa popolazione (oscillante in quei secoli tra i 500 e i 700 abitanti) e limitate risorse economiche sia riuscito ad abbellire i luoghi di culto con tante pregevoli opere d'arte Anche il Cardinale Querini, in visita pastorale nel 1730, si commosse alla vista di quanto i Cainesi avevano profuso nella nuova parrocchiale che gli si presentò come piccolo ma autentico gioiello settecentesco.
È questo uno dei tanti segni della straordinaria fede, devozione e pietà dei nostri padri. Certamente la Beata Vergine, Dio e i suoi santi dovevano essere allora più vicini agli uomini per essere raffigurati ovunque, spesso invocati nel corso di solenni celebrazioni, processioni e Rogazioni, quotidianamente pregati durante il lavoro nei campi o la sera accanto al fuoco.
Èpur vero che. ciononostante non mancarono calamità naturali né altre dolorose prove, ma la siccità, le inondazioni, le carestie, le malattie passarono e non per il potere degli uomini ma quando Dio volle e forse proprio per intercessione dei suoi santi. Anche la peste, dopo aver mietuto tante vittime, lentamente abbandonò le nostre contrade, ma non certo sconfitta dalla scienza di chirurghi, barbieri, salassatori o deputati alla sanità del tempo. Forse contro di essa molto di più potè un pellegrino (S. Rocco) con il suo cane.
Da parte sua, S. Giorgio, da buon soldato continuò per tre secoli, dall'alto della montagna, a sorvegliare la valle insieme a S. Rocco, S. Brigida, S. Barbara, S. Monica, S. Caterina e alla mano di S. Costanzo ch'era in una cassetta collocata in una nicchia scavata all'interno dell'altare della chiesa. Nel silenzio della montagna ebbe la gradita compagnia degli eremiti che custodirono quel luogo (Marco Cretese, 1573; fra Stefano Rizzini, 1600; Ettore Armanno, 1604; Alberto Zanini, 1634 ed altri ancora) ed occasionalmente, quando l'eremo non fu custodito, quella meno gradita di briganti e banditi che colà si rifugiarono.
Tra questi si segnalò un certo Ghidini di Lumezzane, meglio noto come il temibile «Giubileo». Non essendo documentati gravi danni dovuti alla loro presenza, vien da pensare che i briganti abbiano guardato con una sorta di ammirato rispetto a quel possente cavaliere militante in campo opposto.
Il tempo cominciò poi a lasciare le sue tracce e la tela fu sottoposta a ripulitura nel 1801 e a restauro nel 1843. Anche l'eremo richiese diversi interventi per riparazioni, interventi documentati negli archivi parrocchiali. Il degrado divenne più grave e manifesto negli ultimi decenni e non mancò l'atto vandalico di qualcuno che impallinò la tela sparando dall'esterno. Venne quindi staccata, arrotolata e riposta nella sacrestia di S. Zenone.
Oggi è tornata a noi, in quello che doveva essere il primitivo splendore, dopo un restauro difficile, lungo e delicato (durato più di un anno) ma alla fine felicemente concluso dalla società cooperativa Techne di Botticino.
La spesa è di circa 4 milioni, a cui si deve aggiungere un altro milione per una buona cornice. Si tratta di una cifra notevole ove si consideri quanto già speso per precedenti restauri e la necessità di provvedere ad altri massicci interventi sulle altre pale della parrocchiale, l’organo, le vetrate… E’ evidente come per questi lavori sia indispensabile la sensibilità e la generosità di tutta la popolazione (come avvenuto nel recente passato) e quanto sia auspicabile anche l'intervento di enti ed istituzioni in veste di sponsor.
Ne vale la pena?
E stato scritto che una comunità quando non ha memoria del proprio passato è come morta perchè non ha radici; ha scarsa coscienza del proprio presente e nessuna prospettiva per l'avvenire.
Io credo che «memoria del passato» non significhi solo ricerca e riscoperta, ma anche e in primo luogo conservare, tutelare, provvedere affinché altri godano di un patrimonio che non è solo di grande valore artistico, ma segno presente della profonda religiosità di chi ci ha preceduto in questa terrena avventura.
Franco Gatelli.
(dal bollettino parrocchiale Fonte di Vita, in occasione del restauro della pala di S. Giorgio)